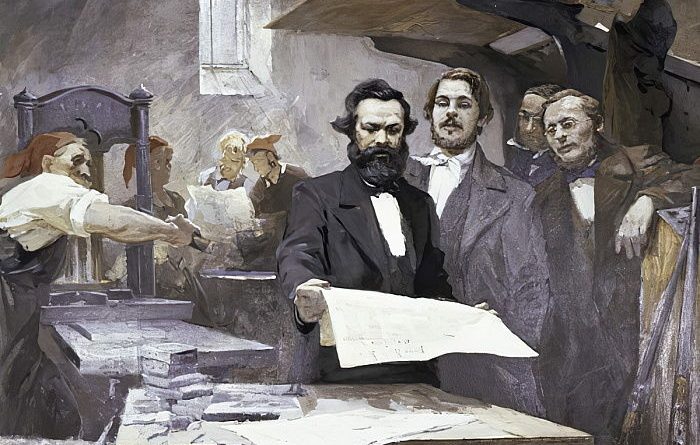LOTTA PER LA FONDAZIONE DEL MOVIMENTO SOCIALISTA ITALIANO (terza parte) di Piero De Sanctis
«Finalmente anche in Italia il movimento socialista è stato posto su un solido terreno e promette un rapido e vittorioso sviluppo. Ma perché il lettore possa comprendere in pieno la svolta avvenuta, dobbiamo rivolgerci alla storia del sorgere del socialismo italiano. Il sorgere del movimento in Italia è legato agli influssi bakunisti. Mentre nelle masse operaie dominava l’odio di classe appassionato, ma al sommo grado indefinito, per i propri sfruttatori, in tutte le località dove si presentava l’elemento operaio rivoluzionario, si era impadronito della direzione un pugno di giovani avvocati, direttori, letterati, commessi, ecc., al comando personale di Bakunin.
Essi tutti erano stati iniziati al mistero dai membri della segreta Alleanza democratica bakunista, il cui scopo era di sottomettere alla propria direzione tutto il movimento operaio europeo e di conseguire il dominio della setta bakunista nella rivoluzione sociale a venire… Fino a quando il movimento fra gli operai era soltanto in germe, ciò riusciva nel miglior modo possibile. Le furiose frasi rivoluzionarie bakuniste suscitavano ovunque gli applausi voluti; persino quegli elementi che erano cresciuti dai precedenti movimenti politico-rivoluzionari, venivano travolti da questo torrente; oltre alla Spagna anche l’Italia era diventata, secondo una espressione dello stesso Bakunin, il paese più rivoluzionario d’Europa. Rivoluzionario nel senso che vi era molto fumo, ma poco arrosto.
In contrappeso a quella lotta in sostanza politica, grazie alla quale è sorto e si è rafforzato il movimento operaio inglese poi quello francese e, infine, quello tedesco, qui veniva condannata ogni attività politica, perché essa implica il riconoscimento dello Stato, ma lo Stato è l’incarnazione di ogni male. Quindi si proibisce la creazione di un partito operaio; si proibisce la lotta per qualsiasi misura protettiva contro lo sfruttamento, ad esempio per la normale giornata lavorativa, per la restrizione del lavoro femminile e infantile; e, cosa essenziale; si proibisce la partecipazione a tutte le elezioni. Al posto di ciò occorrono l’agitazione, l’organizzazione e la cospirazione ai fini della futura rivoluzione la quale, non appena cadrà dal cielo, deve essere attuata senza qualsiasi governo provvisorio, sopprimendo completamente tutte le istituzioni statali o le istituzioni simili a quelle statali mediante la sola iniziativa (diretta in segreto dall’Alleanza democratica) delle masse operaie. Fino a quando il movimento, come abbiamo detto, era ancora in fasce, tutto ciò riusciva bene. La stragrande maggioranza delle città italiane rimangono ancora in una certa misura tagliate fuori dai legami mondiali, ad essi noti solo nella forma di visite degli stranieri…In queste città gli elementi di opposizione sono poco numerosi, sono assai poco sviluppati e per giunta, sono molto annacquati da gente senza occupazione sistematica e permanente, il che è favorito dai rapporti con gli stranieri e dal clima mite…Ma in Italia vi sono anche città industriali, principalmente nel nord; e non appena il movimento ha messo radici fra le masse veramente proletarie di queste città, un tale cibo di qualità scadente non poteva più soddisfare, e questi operai non poterono più permettere che essi fossero tutelati anche per l’avvenire da questi giovani borghesi sfortunati che si sono lanciati verso il socialismo…Ed è accaduto proprio così.
Il malcontento degli operai dell’Alta Italia per la proibizione di ogni attività politica, cioè di ogni vera attività, che esca dai limiti delle chiacchiere vuote e dall’attività cospiratrice, cresceva di giorno in giorno. Le vittorie elettorali dei tedeschi nel 1874 e il risultato da essi conseguito : l’unificazione dei socialisti della Germania [Congresso di Gotha del maggio 1875],erano noti anche in Italia…Quando, infine, nell’Alta Italia, le masse operaie hanno sorpassato i loro dirigenti importuni e hanno dato vita ad un vero movimento al posto di quello fantastico, hanno trovato nel settimanale La Plebe un organo che pubblicava volentieri, di tanto in tanto, allusioni eretiche alla necessità della lotta politica…Il 17 e il 18 febbraio [1877] si è tenuto a Milano un congresso della Federazione dell’Alta Italia. Nelle sue risoluzioni il congresso si astiene da ogni ostilità superflua e inopportuna contro i gruppi bakunisti di membri italiani nell’Internazionale. In esse si esprime persino la disposizione a prender parte al congresso che viene convocato a Bruxelles, congresso che dovrà compiere un tentativo di unire le diverse frazioni del movimento operaio europeo. Ma al tempo stesso esse avanzano con la massima precisione tre punti di importanza decisiva per il movimento italiano:
- Che per assicurare il successo del movimento devono essere impiegati tutti i mezzi possibili, quindi anche quelli politici;
- Che gli operai socialisti devono costituirsi in partito socialista, partito che non dipenda da qualsiasi altro partito politico o religioso, e
- Che la Federazione dell’Alta Italia, a condizione della sua autonomia e sulla base degli Statuti iniziali dell’Internazionale, si considera membro di questa grande associazione, membro che non dipende da tutte le altre associazioni italiane, alle quali, però, essa continuerà a fornire per l’avvenire prove della sua solidarietà.
Quindi: lotta politica, organizzazione di un partito politico e rottura con gli anarchici. Con queste risoluzioni la Federazione dell’Alta Italia ha ripudiato definitivamente la setta bakunista e si è posta sul terreno comune del grande movimento operaio europeo. E dato che essa abbraccia la parte dell’Italia più sviluppata industrialmente – la Lombardia, il Piemonte, il Veneto- i suoi successi non si lasceranno attendere, molto. Di fronte all’impiego degli stessi ragionevoli mezzi di agitazione, corroborati dall’esperienza di tutti gli altri paesi, il vaniloquio dei ciarlatani bakunisti rivelerà molto presto la sua impotenza e il proletariato italiano, anche nel sud del paese, si libererà presto dal giogo degli uomini che fanno derivare la loro missione di guidare il movimento operaio dalla propria condizione di borghesi rovinati ». [dall’articolo di F. Engels: IN ITLIA, del marzo 1877].
Ma prima che si avverasse l’augurio di Engels il proletariato italiano, ancora per molti decenni, dovette lottare su due fronti: su quello economico-sociale contro la nascente borghesia industriale, che su quello secolare del predominio della Chiesa Cattolica Romana.
Alla condanna del liberalismo da parte del pontefice Gregorio XVI (1834-1846), enciclica Mirari vos, e quella di Pio IX Quanta cura (1848-1878), seguì quella di Leone XIII (1848- 1903), Rerum Novarum del 1891 con la condanna del socialismo e del comunismo. Di fronte al diffondersi delle dottrine socialiste e all’aggravarsi della questione sociale (Leone XIII aveva assistito di persona, al tempo della sua nunziatura apostolica in Belgio, all’esplosione del problema sociale), la Chiesa, alla fine dovette prendere posizione anche per orientare l’azione dei cattolici.
Per ostacolare il movimento democratico di lotta del popolo per la liberazione di Roma dalla dittatura papale, l’8 dicembre del 1864, Pio IX pubblica il Sillabo. In esso si condannavano le dottrine professate del liberalismo, del laicismo, del cattolicesimo liberale, del socialismo, del comunismo, la libertà di coscienza, la libertà di pensiero e di azione, la separazione tra Chiesa e Stato, la scuola laica sottratta al controllo dei vescovi, la condanna di tutti i principi della moderna filosofia. Significativa è l’ultima proposizione con cui si chiude il Sillabo: «Sia maledetto chi afferma che il romano pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e colla moderna civiltà» che, insieme alla proposizione che condanna, come pestilenza, il socialismo, il comunismo, le società segrete, società bibliche e le società clerico-liberali, costituiscono l’essenza teorica del Sillabo. [Il Sillabo e dopo: Ernesto Rossi, Ed. Riuniti: 1965]
Nell’enciclica, Quanta cura, Pio IX si richiama alle condanne dei suoi predecessori, specialmente di Gregorio XVI, che aveva qualificato «delirio l’opinione di chi afferma la libertà di coscienza e dei culti essere, un diritto proprio di ciascun uomo, che si ha da proclamare e stabilire per legge in ogni ben costituita società, ed i cittadini avere diritto ad una totale libertà, che non deve essere ristretta da nessuna autorità o ecclesiastica o civile, in virtù della quale possano palesemente e pubblicamente manifestare e dichiarare i loro concetti quali che siano o verbalmente, o per mezzo della stampa o in altra maniera». Ed inoltre «la soluzione avanzata dai socialisti, con la trasformazione della proprietà privata in collettiva, è falsa ed ingiusta, perché offende i diritti naturali» (secondo Pio IX «diritto naturale è la proprietà privata»). Ed ancora, «non è possibile togliere dal mondo le disparità sociali, così come non è possibile eliminare il dolore, levar via affatto le sofferenze del mondo non v’è né forza né arte che possa; anzi le sperequazioni tra ricchi e poveri è premessa indispensabile nell’esercizio delle virtù cristiane della carità e della pazienza».
Teramo 3 settembre 2925